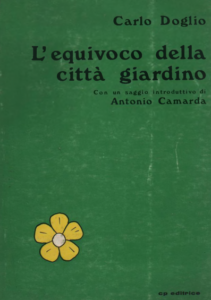
Edito da CP, Firenze, 1974, XXXI+126 p.
Introduzione dell’autore alla seconda edizione
[…]
Le nuove città come centri storici. Oscure nubi solcano cieli gremiti di portenti: è un po’ difficile, in una situazione del genere, continuare a sgomitolare sillogismi fondati su una ragione che di momento in momento si raggrinza e svuota. La mia intenzione è di fornire al lettore alcuni materiali, o meglio linee di riflessione, che poi lui stesso elabori e faccia proprio contesti — una partecipazione, insomma — nella lettura in filigrana di idee e fatti della pianificazione urbanistica e architettura, della pianificazione e organizzazione territoriale, di Gran Bretagna vista dall’Italia, e del nostro medesimo paese per eventuali occasioni d’intervento, ovviamente progettuale cioè globale. Sono persuaso che la contemporanea società industriale (o in via di industrializzazione, che per i ciechi e sordi sarebbe « di sviluppo ») corra sempre più velocemente in direzione della propria estinzione, contrassegnata da fasi crescenti di massificazione e di predomini totalitari e dal grido del « sempre più grande! ». Le tecniche costruttive, sia rispetto alle strutture urbane e residenziali — la città, la casa — sia rispetto alle infrastrutture così fisiche (strade, ferrovie, ecc.) come immateriali (telegrafo, radio, tv) sono a traino di quella corsa. Sviluppano una tecnologia che permetta e faciliti il « sempre più concentrato », « sempre più veloce », « sempre più vasto », con le collaterali risultanze di anomia, alienazione, espulsione dell’uomo dall’ambito del lavoro creativo per immetterlo in un tempo « libero da nulla », per niente « liberato ». Si parla di megalopoli, e delle sue congeniali tecnologie. Noi ancora non ci siamo, a quel punto: che è poi un punto di « non ritorno »: dinosauri disperati che risucchiano tutto il midollo della terra, che svuotano i cicli e disseccano le acque. Le metropoli costituiscono il momento di passaggio, quando si è ancora in tempo a mutar direzione, a invertire la marcia. Lasciar trascorrere quel momento, di decine d’anni vediamo, senza intervenire, o peggio intervenendo d’equivoci, è esiziale. Un equivoco storico, nel contesto britannico, sono le città-giardino. È la reazione del decentramento alla concentrazione, del piccolo al grande, del sociale all’individuo nell’ambito delle riflessioni di fine Ottocento e inizio di secolo nutrite di Henry George e di superamenti filantropici. Il « progetto » non ha importanza, prevale la « organizzazione » secondo schemi metà manageriali e m età burocratici. Si cerca di esorcizzare il dormitorio e il frastuono, concludendo nella astrazione delle partite a scacchi. Le « nuove città » sono la stessa reazione, entro un diverso brodo culturale che sarà, adesso, quello post-bellico 1945. Lo nutre l’alleanza del capitalismo liberale e del socialismo di Stato contro il primo mostro dei nuovi tempi, il primo grumo della illibertà razionalizzato tecnologicamente, il nazismo. Nutrite di laborismo come le città-giardino erano fertilizzate di filantropismo e imprenditoria, conducono una battaglia di retroguardia contro i sobborghi e le periferie intente a non urtare — quale libertà?! — la nuova piccola borghesia d ’estrazione operaia. Una forma simile è quella del ritorno ai « centri storici » nel quadro urbano e territoriale italiano. Le nostre nuove città sono i centri storici. Non si è capito che codesti sono del tutto « antichi », cioè incapaci di fornire elementi di progresso, di svolgimento alter nativo… ma forse non lo si vuole capire. Eppure è tanto semplice! quando siano socio-urbanisticamente, e architettonicamente, validi, i centri in questione sono « risolti in sé », monumenti globali, pezzi archeologici e nessuno pensa di andare ad abitare, di fame soluzione d’abitazione e vita, in un tempio greco o rom ano, o azteco o druido o così via. Quando non attingono la sopracitata validità, e da questo punto di vista sarebbero storicizzabili, cioè adatti a essere modellati in forme ulteriori, la verità è che codeste forme sono de boli, fiati di acquisizione culturale borghese beninteso secondo la nuova borghesia che non è quella dell’Ottocento (britannico?) ma di adesso 1974, contesta di terziarizzazioni, di dipendenze statuali (e così via nella scala fino al quartiere), di aneliti d’imitazione. Così, in un paese come l’Italia, diventa tipico il dilemma che riproduce a scala urbanistica quello che in termini architettonici fu il revival del neo-liberty. La cosa più divertente, segno d’altronde dei tempi, è che a poco a poco si andrà scoprendo l’infantilismo di una polemica tra i difensori del restauro conservativo e i settatori dell’intervento moderno: poiché l’intervento moderno, fatto in stile, è la stessa cosa della conservazione e ambedue non muovono aria: sotto riversi cieli campane sterilizzate, grandi fatti tecnologici e la vita sfugge dal pianeta terra. In un paese come la Gran Bretagna, lo stesso problema è riproposto, in termini ovviamente più avanzati, dallo scontro fra planning (urbanistica?) e design (architettura?). È tutto un coinvolgersi di razionalismo importato e di organicismo rielaborato tra mite l’illuminismo delle buone e cattive maniere in architettura. Tutto è « civile », grande conquisa per vero. Ma che appartiene al fluire della storia configurata dagli inizi del Settecento a oggi, e che oggi non ha più futuro (se non quello della definitiva spogliazione delle risorse non rinnovabili, dello stupro della natura e mostri, oh quali e quanti sono già tra noi!). L’alternativa è globale. Si tratta di tornare ai discorsi semplici e diretti di antiche formulazioni che vanno da uomo a uomo, senza intermediari o meglio senza intermediazioni di potere. Codesto retroterra culturale va riconquistato in ogni sfera, ed espresso in ogni ambito. Non ci può essere una tecnologia dal volto umano se codesto volto non riappare al di là dei fumi linguistici, dei rictus scientifici messi in circolazione per nascondere l’ignoranza (nel senso che « ignoriamo » dove si sia diretti) e acquisire autorità — sacerdoti dell’ignoto, e dell’inconscio. Le forme vanno nuovamente modellate nei loro propri materiali, non desunte da schemi e da produzioni inventate per « sveltire il lavoro, toglier di mezzo la m ano umana, ingrossare i profitti ». È difficile non restare abbacinati da esempi nutriti di più esperienza e pragmatica che non ci sia usuale — ma anche là tutto è fatica e incertezza, e dove sembra tutto chiaro è il lucido di una riproduzione fotografica, dove è la vita?
Carlo Doglio
Bologna, 1 Settembre 1974
Note dell’Archivio
-Nel frontespizio viene riportata la seguente nota: “Esce per la prima volta a puntate su «Volontà», 1953, a. V a, nn. 1/2-5-4-5-6/7.
Viene poi riunito in opuscolo: Napoli, 1953, edizioni R.L., pp. 68. Ampi stralci sono apparsi anche su « Urbanistica », 1953, a. XXIII, n. 13, pp. 56-66.
-In questo libro sono riportate le due Introduzioni curate dall’autore
