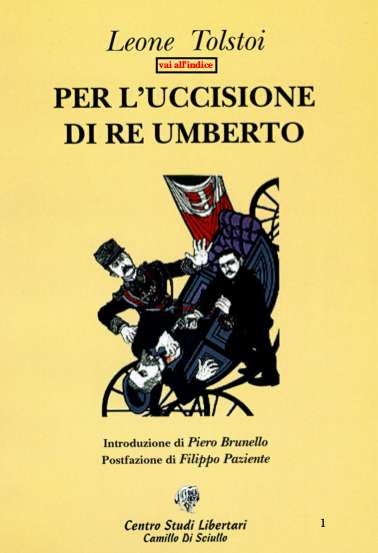
Edito da Centro Studi Libertari “Camillo Di Sciullo”, Chieti, 2003, 77 p.
Prefazione di Arturo Labriola
Il Tolstoismo è uno stato d’animo che nella storia del socialismo si è prodotto un numero infinito di volte. Alcune persone, in Russia e fuori, si sono proposte varie volte di dimostrare che, come concezione filosofica, il tolstoismo non è originale. Non vi è nessun dubbio a questo proposito. Nel nostro mondo occidentale i precursori più clamorosi del tolstoismo furono i quacqueri. Essi hanno appunto sostenuto, con una energia morale che non si smentì nemmeno innanzi al supplizio, la dottrina dell’eguaglianza cristiana e della resistenza al male. George Fox e James Naylor furono certamente poveri scrittori, ma per l’impavidezza e la costanza con la quale predicarono e praticarono il loro nuovo Vangelo, essi sono rimasti un esempio ai loro discepoli e al paese. Ma il quacquerismo non è che uno dei tanti esempi che si possono a questo proposito invocare. La dottrina della non resistenza al male è in sostanza l’ultima protesta che l’impotenza oppressa e la giustizia conculcata possono avventare contro l’iniquità. Il pensiero segna l’ultima e più invincibile antitesi fra il male e il bene, allorché pronunzia che nemmeno per salvarsi oserebbe il bene brandire le stesse armi di Satana. Questa situazione è di una grandezza morale senza confronti. L’iniquo e il protervo sono avvertiti che essi appartengono a un’altra umanità, ad una umanità che è stata idealmente separata dal mondo degli uomini, che siano veramente uomini: creature di dio, dice anzi il mistico. Innanzi all’adepto della religione della non resistenza, il violento e il malvagio sono immediatamente relegati nel mondo della bestialità. Essi operano il male, certamente, ma, alla coscienza dell’illuminato, come ciechi meccanismi, nei quali il destino legò una forza malefica, inesorabile nelle sue manifestazioni, ineffabile nella sua intima materialità. Resistere a loro non si può senza confessare una sorta di parentela. Ma non è che una illusione dello spirito, o, meglio, una trappola della ragione. Il buddista che crede di aver vinto il desiderio, il tolstoiano che crede di non resistere al male soltanto per un atto della sua volontà, sono vittime entrambi di una comune allucinazione, nata anch’essa dall’istinto della vita, cioè dalla forza radicalmente opposta al buddismo e al tolstoismo, la quale allucinazione consiste appunto nel confondere un atto di necessità con un atto di libertà, una posizione personale con una posizione assoluta. Lo stesso desiderio della estinzione è un desiderio, cioè una forma dell’esistenza, lo stesso imperativo della non resistenza una maniera della resistenza; espressioni attenuate e fluide di posizioni dello spirito più rilevate e solide, che inducono immediatamente alla reazione risoluta e consapevole, all’affermazione radicale ed intransigente. Quando lo spirito non sa o non osa o non può oltre mettere chiaramente e risolutamente le proprie condizioni, esso si rifugia in quella forma ipocrita della resistenza che è la non resistenza, in quella maniera larvata del desiderio che è la rinunzia al desiderio; ma facendo questo esso resiste e desidera, come avrebbe resistito e desiderato se il suo fine consapevole fosse stato il desiderio e la resistenza! Perciò il destino di queste filosofie è di apparire e sparire in determinate situazioni della storia. Senza parlare del buddismo orientale, in quanto maniera di spirito che sia nata al contatto di una particolare anima della specie e in una tradizione singolare del peniero; ognuno intende che, nel nostro mondo occidentale, tanto le dottrine buddiste, quanto le dottrine tolstoiane non possono configurare che necessità renitenti e intollerabili dello spirito, incapace di porre risolutamente le sue condizioni. Soppressa la coazione, superato il limite, rimosso l’ostacolo storico, l’uomo rinnega la sua stessa ideologia e si dedica all’azione. I quacqueri crearono insieme il moderno sistema di istruzione popolare in Inghilterra e, per il tramite di John Bellers, rivissero nel socialismo dell’Owen. Quanto ai discepoli del Tolstoi, il loro posto è stato accanto agli uomini della rivoluzione. Ma, soffocata l’azione, tolto al pensiero ogni mezzo di estrinsecazione esterna, che cosa gli resta se non predicare la teoria della non resistenza al male? Ma questo è già un combattere, già un predisporre gli uomini alla lotta! La rinunzia alla resistenza è il più formidabile atto di accusa che si possa pronunziare contro l’iniquità in auge. Il braccio, spezzato ed infranto, ricade inerte; lo spirito vigila ancora e giudica. Esso attende che il lavorio lento ed operoso della natura ripari i tessuti mortificati, rinsaldi le membra fiaccate ed ispiri nei muscoli una novella energia, capace di cimentarsi alle cresciute difficoltà. Intanto giudica. Condanna la violenza, ogni violenza, ma la violenza è condannata nel suo nesso causale, nelle ragioni prime che la propongono, nel sistema che organicamente la genera come azione e come reazione. Tolstoi non assolve Caserio, Sofia Perowskaia e Gaetano Bresci, ma riconosce che la loro arma fu temperata nei delitti di coloro stessi che essi colpirono. Non è più la non resistenza al male; è la condanna di quella specie di resistenza che non viene ad eliminare il male. E qui appare la vera, insanabile contraddizione del tolstoismo. La reiezione della violenza è operata dal Tolstoi in base al criterio economico della sua non convenienza rispetto al fine. Che cosa dice il Tolstoi? È inutile respingere la violenza con la violenza, perché ogni violenza perpetua il male. Questo stesso criterio utilitario gl’impedisce di comprendere il valore etico dell’attentato personale. Egli lo giudica come la piccola gente che fa professione e mestiere di socialismo parlamentare. Anche costoro condannano gli attentati personali; anzi hanno anche trovato una bella formula e dicono che “la vita umana è sacra”. La vita umana non è affatto più sacra di quella di uno scarafaggio o di un leone, perché la natura sperpera allegramente e con la stessa indifferenza la vita di tutte le sue creature. Sarebbe più semplice dire che gli attentati personali non sono convenienti perché compromettono i successi dei partiti parlamentari. Tolstoi naturalmente non può essere fatto discendere a questo livello; ma ognuno scorge che il criterio col quale egli giudica gli attentati è di convenienza. Non giovano, dice, alla causa. L’attentato personale è un fatto che è al di fuori degli apprezzamenti utilitari. Esso è concepito dal suo autore come un atto di riparazione sociale in un caso in cui la coscienza morale degli uomini è rimasta turbata. L’autore dello attentato – e dico tanto dei più remoti, come dei prossimi – è un uomo nel quale il sentimento della giustizia è diventato così squisito che non può più tollerare una infamia trionfante o una sopraffazione infelice. La violenza, la crudeltà, la frode e la turpitudine lo scuotono nelle intime fibre e lo concitano alla reazione. Egli non deve preoccuparsi se il suo gesto riparatore del male già compiuto sia per iniziare un’altra serie di mali. Il suo sentimento è più immediato. Un maleficio venne consumato; un delinquente trionfa del proprio delitto nella sicurezza della propria impunità; ed egli, inesorabile giudice, stende ed esegue una sentenza riparatrice della sua coscienza morale offesa. Psicologicamente parlando, qui siamo fuori il terreno della convenienza e della opportunità. È dunque in nome della sua coscienza morale che l’esecutore agisce, vale a dire di quella forza che nel tolstoismo è posta al di sopra di tutte le altre. All’atto in cui Tolstoi lo condanna, egli condanna la sua stessa dottrina. L’altro è più intero. Ora questa stessa contraddizione è la riprova di quello che affermavo in principio, essere il tolstoismo una filosofia di transizione in seno al socialismo. Il tolstoismo non può vivere se non fin quando, duri l’incapacità o il desiderio di agire. Appena il processo naturale delle forze rivoluzionarie ha ripreso il suo corso, il tolstoismo s’immerge nelle onde della coscienza individuale per trasformarsi in suprema idealità di perfezione individuale, in quanto condizione del bene collettivo. E come tale, suprema è la sua efficacia.
Link Download: https://mega.nz/file/TYBHiSbB#vCKLw3XOqdXyL0i5vSowdH_aDZBAeVrZJSGoP1p3epU
Note dell’Archivio
– Nell’introduzione, Piero Brunello scrive che “la prima traduzione in italiano dell’articolo di Tolstoj uscì nella rivista «La vita internazionale», organo della Società per la pace e la giustizia internazionale, diretto da Ernesto Teodoro Moneta, fondatore dell’Unione lombarda per la pace e l’arbitrato internazionale. L’articolo uscì nel numero del 20 ottobre 1900 con il titolo Non uccidere! A proposito dell’assassinio di Umberto I, «in versione molto ridotta». La rivista aveva pubblicato due anni prima l’articolo di Tolstoj Carthago delenda, ed era stata sequestrata dalla Procura di Milano per «eccitamento alla disobbedienza della legge», malgrado una nota redazionale avesse preso le distanze dall’invito di Tolstoj, «paradossale e anarchico», di rifiutare il servizio militare. La paura di un nuovo sequestro e la distanza della rivista dalle posizioni di Tolstoj, consigliarono la redazione a pubblicare Non uccidere! con molti tagli. La traduzione era condotta su due differenti versioni uscite in due riviste francesi: «qui e là – avvertiva una nota – fummo costretti ad attenuare» (per esempio Guglielmo II non veniva mai nominato), di disobbedienza non si parlava, e l’appello finale si riduceva a questo auspicio: «Non bisogna in nessun caso uccidere né Alessandro né Carnot, né Umberto, né altri: ma unirsi per far condividere loro quest’opinione che nessuno ha diritto di uccidere facendo la guerra». Nel 1905 Non uccidere! venne compreso nella raccolta di scritti Ai governanti. Ai preti, pubblicata da Sonzogno nella traduzione di Maria Salvi. Sonzogno era la casa editrice del quotidiano «Il secolo», del quale Teodoro Moneta era stato direttore per quasi trent’anni. Anche in questo caso non si tratta di una versione integrale: viene attenuato il giudizio di Tolstoj secondo cui un regicidio non è un’azione particolarmente crudele se paragonato a quelle «incomparabilmente più crudeli» commesse dai re, e soprattutto vengono omessi gli appelli finali al rifiuto di pagare le tasse e di prestarsi al servizio militare.
L’articolo fu pubblicato in versione integrale per la prima volta nel 1908 dal quindicinale anarchico «Il pensiero», diretto da Pietro Gori e Luigi Fabbri, con il titolo A proposito dell’uccisione di re Umberto, sulla base del testo francese pubblicato nella raccolta Les Rayons de l’Aube nel 1901, ben conosciuta negli ambienti anarchici. In una nota redazionale, inserita nel punto in cui Tolstoj presenta Bresci come un uomo armato da un gruppo di anarchici, i responsabili del periodico dichiarano di essere «antitolstoiani recisi» e di dissentire dall’articolo «in numerosi punti», ma di pubblicarlo comunque per la prima volta in italiano per le affermazioni coraggiose che vi si trovavano.
L’unico taglio operato dalla rivista riguarda le citazioni bibliche ed evangeliche premesse all’articolo. In un punto poi è inserita un’aggiunta: nell’originale russo e nel testo francese si legge che i re e gli imperatori dovrebbero stupirsi della rarità di questi crimini, mentre in quello italiano si legge: «I re e gli imperatori, se fossero logici, quando l’ira popolare si abbatte su qualcuno di loro, dovrebbero meravigliarsi della rarità di questi delitti». L’aggiunta dell’espressione «ira popolare» sembra riprendere quello che aveva scritto Malatesta. ”
– Come riportato nel testo, “le date delle lettere e del diario di Tolstoj sono secondo il calendario giuliano adottato in Russia prima della rivoluzione: fino al 12 marzo 1900 sono indietro di dodici giorni rispetto all’Europa occidentale, dopo lo sono di tredici. Perciò il 7 agosto 1900 corrisponde, in Italia, al 20 agosto.“
