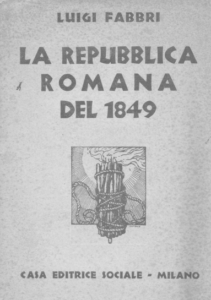
Edito da: Casa Editrice Sociale
Luogo di pubblicazione: Milano
Anno: 1949
Pagine: 34
File: PDF
Introduzione/Premessa/Presentazione/Sinossi/Quarta di Copertina/Sintesi:
Iniziamo i Quaderni della Sociale con lo studio di Luigi Fabbri sulla Repubblica Romana del 1849 non solo per la sua attualità in occasione del centenario, ma anche per rendere omaggio alla memoria di un onesto e tenace lottatore che tutta la sua vita dedicò alla causa della giustizia sociale. La prima volta venne pubblicato nel 1925 a puntate nella rivista L’università libera edita dalla Casa Editrice Sociale. Cogliamo l’occasione per ricordare agli amici vecchi e nuovi che quest’anno si compiono quarant’anni da quando nel lontano 1909, iniziammo la nostra attività editoriale… In questi Quaderni è nostra intenzione raccogliere quanto di meglio si è prodotto nel campo della libera cultura e che non sia già stato da altri pubblicato. Per una efficace formazione di uomini liberi crediamo sia necessario conoscere anche i piccoli testi e le tendenze meno seguite. Per la loro diffusione contiamo sulla solidarietà di tutti gli amici. Di ogni quaderno vengono stampate soltanto mille copie.
Nota dell’Archivio
– La ripresa della casa editrice diretta da Giuseppe Monnanni dopo il secondo conflitto mondiale, fu, stando a quanto riportato da Schirone Franco nel capitolo “La Casa Editrice Sociale. Un esperimento di cultura anarchica (1909-1933)” – ed inserito in “Leda Rafanelli: tra letteratura e anarchia. Atti della giornata di studi “Leda Rafanelli. Una vita anarchica” tenuta a Reggio Emilia il 27 gennaio 2007”, Biblioteca Panizzi Archivio Famiglia Berneri – Aurelio Chessa, 2008 -, difficoltosa per le condizioni in cui si trovava il territorio e il movimento anarchico italiano dopo la guerra. La morte della casa editrice avviene, scrive Schirone, non solo perché l’editore “sarà duramente colpito da problemi di salute e non potrà continuare la sua opera, ma anche perché lo scenario politico e sociale dell’Italia del secondo dopoguerra è radicalmente cambiato rispetto a quello che aveva visto nascere le tante iniziative editoriali di Monanni. Il movimento anarchico italiano è stato perseguitato e quasi annientato in vent’anni di totalitarismo, i suoi migliori militanti rinchiusi nelle carceri, o al confino, o esuli nel mondo, o assassinati nelle piazze d‟Italia (e non solo di questa); il sindacalismo rivoluzionario dell’USI non esiste più; le diverse correnti individualiste sono scomparse ed i migliori hanno fatto scelte diverse; la lotta partigiana ha determinato altre tematiche, altre scelte e nuovi bisogni; la presenza nel movimento operaio è stata, anche volutamente, minima e, nel suo complesso, l’anarchismo non è stato in grado di crescere pur avendo avuto i presupposti nell’immediato dopoguerra, quando, a seguito della lotta partigiana, numerosi giovani si sono avvicinati al movimento facendo ben sperare in una ripresa.”
