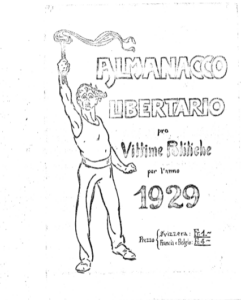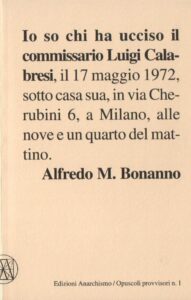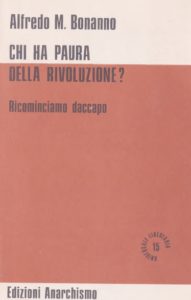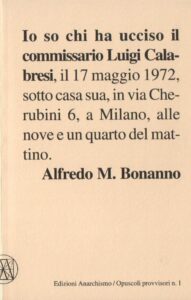
Edito da Edizioni Anarchismo, Trieste, Novembre 2013, 120 p., Quarta Edizione
Introduzione alla prima edizione
Io so chi ha ucciso il commissario Luigi Calabresi, il 17 maggio 1972, sotto casa sua, in via Cherubini 6, a Milano, alle nove e un quarto del mattino. L’affermazione è grave, non per le implicazioni giudiziarie, per carità, delle quali non mi curo minimamente, ma per ben altri motivi, ed è di questi motivi che voglio mettere a parte i miei attenti lettori. In fondo, se riflettiamo un poco, di che cosa possiamo essere sicuri? La mattina ci svegliamo, mettiamo i piedi fuori dal letto, facciamo colazione in fretta, voliamo verso la scuola, il lavoro, i più vicini giardinetti per trovare gli amici, insomma, ognuno verso le proprie faccende quotidiane. La sera, ritornando a porre le spalle sul lenzuolo, quasi sempre lo stesso della sera prima, di che possiamo dirci certi dell’insieme di fatti che abbiamo visto scorrere sotto i nostri occhi durante l’intera giornata? Non appena puntualizziamo un avvenimento, per quanto semplice, il caffè che abbiamo preso la mattina al bar, ecco che tutto il contorno si fa confuso, tende a sfocare nei suoi dettagli, e ogni aspetto scompare in un desiderio inappagato di precisione. In definitiva, abbiamo una memoria di quello che ci è accaduto, di quello che abbiamo fatto, ma le nostre affermazioni, riguardo i singoli avvenimenti, sono tanto inadeguate da farci concludere che non possiamo dirci certi di niente. Ma com’è possibile, direbbe qualcuno? La risposta è semplice. Noi siamo certi, e sempre dentro limiti a volte consistenti e gravissimi, solo di quello che veramente ci interessa, di quello che si è talmente avvicinato ai nostri personali sentimenti, bisogni, desideri, sogni, progetti, da costituire pugno nello stomaco. Ricordiamo solo i pugni nello stomaco.
Di per sé, la vita non ci riserva molti pugni nello stomaco, e forse è meglio così.
Pensate cosa sarebbe una vita continuamente vissuta al limite della tensione emotiva, fin quasi a scoppiare sopraffatti dall’adrenalina. Un poco di calma, per carità. Ma, poiché non siamo bestie da soma, ma uomini e donne ansiosi di viverla questa vita, ecco che la guardiamo in maniera selettiva. Filtriamo i fatti che ci accadono attorno, non solo quelli che vediamo direttamente con i nostri occhi, ma anche quelli che le grandi protesi moderne dei giornali e della televisione ci consentono di cogliere, fatti distanti migliaia di miglia, lontani nello spazio eppure così vicini come se accadessero nel cortile di casa nostra. Abbiamo fatto l’abitudine a questi fatti, ma ce ne sono alcuni che si presentano in modo tale da colpirci profondamente. Che vuol dire questo essere colpiti, per giunta in profondità? Vuol dire che restiamo a bocca aperta, mentre una sensazione di dolore, di ansia, di indignazione, di disgusto, oppure, il che fa lo stesso dal punto di vista dei meccanismi biologici che si scatenano nel nostro corpo, di gioia, di entusiasmo, di ebbrezza, ecc.
Questi accadimenti entrano in noi e vi si suggellano nella nostra certezza. So bene che non c’è certezza alcuna, se la si considera in termini di oggettiva certezza valida per tutti, se la si pretende verificare con il bilancino del farmacista, ma quando il sangue ribolle nelle nostre vene per i quindici morti straziati dentro la sala centrale della Banca dell’Agricoltura di Piazza Fontana a Milano, passassero cent’anni, ci sentiremmo lo stesso certi di un fatto indegno, che solo miserabili servitori dello Stato potevano compiere. Ecco il genere di certezza di cui voglio parlare. Tutte le volte che penso a Pinelli gettato dalla finestra della stanza del commissario Calabresi nel cortile interno della questura di via Fatebenefratelli a Milano, il sangue mi ribolle nelle vene. Quindi anche di questo sono certo. Mille legulei organizzati insieme per spiegarmi le ragioni del povero commissario sbalordito dal poderoso colpo di reni di Pinelli per andare a volteggiare nell’aria notturna di Milano, non possono convincermi. Non ho nemmeno bisogno di leggere le testimonianze dei compagni presenti nelle altre stanze che udirono l’accalorarsi dell’interrogatorio, e le imprecazioni che precedettero e seguirono l’uccisione di Pinelli. Non aggiungono nulla alla mia certezza, queste testimonianze. Allo stesso modo non tolgono nulla gli scagionamenti di tribunali, o le dichiarazioni filiali di giovani uomini cresciuti all’ombra della colpa paterna, o i ricordi sudaticci di una vedova per la quale non ho mai provato compassione. Un uomo deciso, sicuro di sé, messo in caricatura perfino in un film, ma padrone della situazione. Era lui la punta di diamante della questura di Milano nel momento in cui scoppiano le bombe, era lui a darsi da fare sulla spinta degli avvenimenti, forse più grandi di lui, ma non di certo capaci di stornargli il cuore verso un moto di correttezza, prima di tutto verso se stesso. Ma di che correttezza può essere capace uno sbirro, e per giunta uno sbirro che vuole fare carriera a qualsiasi costo? Nessuno parla più di questa persona in modo concreto, non potendo sembrare un mito, sembra almeno un fantasma. Gli anni passati hanno annacquato il personaggio, la morte sembra avere appiattito le caratteristiche in una iconografia da martire statale. Il povero Calabresi, trentaquattro anni, un fiore di gentiluomo, con moglie incinta e due figlioletti. Un appartamentino al terzo piano del n. 6 di via Cherubini, una casa modesta. Dopo la morte, la moglie dovette attendere quasi un anno per avere 156.000 lire al mese di pensione. Che tristezza. Ma il povero Calabresi vedeva la vita sotto un’altra prospettiva. Voleva essere un vincente, giocava sporco, ed era riuscito a costruire attorno a sé la fama di duro, di imbattibile. Dappertutto arrivava per primo, schiacciava tutta la concorrenza, i suoi collaboratori lo odiavano, i suoi superiori lo temevano. Uomo da karatè e da culto della forza, era talmente ipocrita con tutti da farsi passare per un sentimentale, per un cattolico praticante, per un timorato di Dio. In fondo, quest’insegnamento l’aveva appreso in America, dove era stato a lavorare con la Cia. Un’esperienza, all’epoca, fatta da pochi super poliziotti italiani.
In quei febbrili giorni del dopo strage a Milano tutti avevano paura di tutti. Il segno del terrore cominciava per la prima volta, seriamente, a penetrare l’aria provinciale e sempliciotta del nostro paese. Anche la città industriale per eccellenza, in fondo, non aveva mai vissuto un’epoca come quella che si accingeva a vivere. E la gente quasi lo sentiva nella pelle questo tragico discorso nuovo che stava per aprirsi.
Perché Pinelli? Perché non lo sappiamo, non lo sapremo mai. Poteva toccare a un altro compagno. La prova di buttare giù qualcuno dalla medesima finestra dello studio di Calabresi era stata fatta mesi prima con Braschi, poteva essere lui a cadere rimbalzando sui cornicioni. Gli è andata bene. Il contesto degli attentati alla Fiera campionaria non era all’altezza di quello di Piazza Fontana.
Raffazzonare al meglio la tesi della pista anarchica era compito suo, era lui lo specialista degli anarchici milanesi, e degli altri che avevano rapporti con i compagni di Milano. Chi meglio di lui poteva raccogliere le fila del discorso di già iniziato da Ventura, con la pubblicazione dei testi anarchici fatta da una casa editrice dichiaratamente fascista e finanziata dal Ministero? In fondo, la scelta degli anarchici era di già in corso da mesi, la prova generale era stata fatta con le bombe della Fiera campionaria. Molti i compagni in galera proprio in quel momento. E lì attorno, a girare ben bene le cose, il povero Calabresi, con il suo vestito stirato di fresco, il suo atteggiamento educato e duro, la sua cultura (si fa per dire, ma sempre qualcosa in prestito riusciva a prenderlo qua e là), la sua velocità nel prendere decisioni.
La velocità nelle decisioni. Un uomo che aveva lavorato per la Cia non poteva avere che la velocità degli uomini della Cia, spietati e freddi nell’esecuzione del loro lavoro. Solo tempi molto più vicini a noi hanno smontato questi luoghi comuni, facendo vedere come i Servizi Segreti, dalla Cia al MI5, al famigerato Mossad, altro non sono che bande di assassini prezzolati e garantiti dell’immunità statale, spesso anche un branco di incapaci e di sprovveduti, dotati di mezzi che a un certo punto li fanno più grandi e più forti di quello che veramente sono. Ecco, il commissario Luigi Calabresi era uno di questi assassini prezzolati e garantiti. Attorno a lui si era creato il mito dell’imbattibilità, della forza decisionista che abbatte tutti gli ostacoli di fronte a sé. Una prima incrinatura questo mito l’aveva avuto al processo contro “Lotta Continua”, dove Calabresi era apparso in difficoltà. Lo si accusava esattamente di quello che stiamo dicendo qui, di avere ucciso, o almeno partecipato all’uccisione di Pinelli. I balbettii di risposta sono ancora nel ricordo di tanti compagni. Il 17 di maggio fu un giorno infausto per il grande commissario. Tutto sembrava dovesse andare come sempre, la solita routine della mattina: la colazione, il saluto alla moglie incinta, i due figlioletti, uno di due anni e uno di undici mesi, che scenetta familiare. Anche il boia ha una famiglia. Non sembra possibile, ma è così. E la famiglia del boia vede il lavoro del boia come quello di un qualsiasi funzionario dello Stato, per giunta di un certo livello, richiedendo il lavoro di boia specializzazioni che non tutti possono assolvere. Dietro la maschera che nasconde il boia c’è posto anche per la prolifica moglie e la numerosa figliolanza. Quell’infausto giorno, più o meno alle nove di mattina, il commissario Luigi Calabresi scende in strada. Lì lo aspetta il suo destino, esattamente alle nove e quindici minuti, sotto forma di due pallottole, una prima e una dopo. Referto: discontinuazioni craniche, meningo-cerebrali, da proiettile da arma da fuoco (regione occipitale destra).
L’autoambulanza della Crocebianca di Vialba urla la sua urgenza per le strade della metropoli. Alle nove e trentasette minuti il commissario Luigi Calabresi muore all’ospedale S. Carlo.
L’autopsia sul cadavere di Pinelli fu eseguita dai professori Ludovi, Mangigli e Falzi. Chi sono costoro? Non lo so. Dei tagliaossa qualsiasi? Non credo, almeno uno di loro era un uomo dei Servizi, come è apparso in una nota marginale pubblicata dai giornali anni dopo. Perché questa presenza? Perché, ancora una volta non si sentivano sicuri che tutto fosse stato fatto a dovere (troppa gente nella stanza di Calabresi?), e volevano chiudere al più presto, massacrando in fretta e furia quel che restava del nostro compagno. Una cosa è certa, che se il lavoro di Calabresi fu un macabro pasticcio (all’improvviso risultò che Pinelli portava ai piedi tre scarpe), quello dei notomizzatori fu fatto alla perfezione. Dopo, nessuna controperizia fu possibile. Calabresi, dopo essere uscito dal portone di casa, va verso il salvagente nel centro della via dove era parcheggiata la Cinquecento della moglie. Ai due lati una Primula e una Opel. Il primo colpo lo coglie alla spalla destra, cade, il secondo gli fa saltare parte del cranio. Lo spazio tra la Cinquecento e l’Opel si riempie a poco a poco di sangue. La gente presente non accorre subito, quasi non si è accorta dei colpi d’arma da fuoco. Nell’aria primaverile sembravano scoppiettii d’una vecchia auto. Poi qualcuno scorge il corpo bocconi, il sangue che continua ad allargare la sua chiazza purpurea. Si chiama la polizia, i carabinieri, l’autoambulanza, insomma tutto quello che accade di solito in questi casi, accade, come in un vecchio copione abusato. Solo che stavolta accorrono anche gli alti vertici della polizia milanese. Guida ha gli occhi pieni di lacrime. Il vecchio custode dei penitenziari fascisti, sperimentato a tanti misfatti e a tante torture, si commuove nel vedere il corpo del fido collaboratore a terra, riverso nel proprio sangue.
Il funerale del commissario finestra è fastoso, moltissime corone di fiori. Il cadavere viene portato in chiesa. Il vescovo ausiliare di Milano celebra il rito funebre: “Fulgido esempio di dedizione al dovere”. È incredibile come questa gente non abbia il minimo senso di pudore. Il cardinale Colombo, riferendosi ad una dichiarazione della signora Gemma Calabresi, afferma: “Il fiore più bello sbocciato sul sangue del commissario ucciso è il perdono della vedova”. Roba da non crederci. Perdono. Che parola magica. Bisognerà aspettare degli anni per sentirla ripetere di nuovo, da altra gente, in altri contesti, ma sempre riguardo la morte di Calabresi. Ma, andiamo con ordine.
Di quella mattinata di maggio qualcuno, dopo tanti anni, sembra ricordare qualcosa. Che splendido e meraviglioso meccanismo è la memoria. La memoria dei pentiti, poi, meriterebbe uno studio a parte. In quel di Massa c’è un tizio che vende crêpe, che ha un chiosco di crêpe, forse venderà anche cocacola e aranciate, non lo so, comunque ha tutta l’aria di un onesto bottegaio che tira a campare. E invece sotto il suo sguardo bonaccione si nasconde un pericoloso criminale. In più, questo criminale pericoloso parla, racconta delle storie, narra di quello che fece la mattina di quel 17 maggio 1972 in via Cherubini, quando a bordo di una macchina aspettava, aspettava, aspettava. Ma chi aspettava? Il nostro amico fa un nome, poi ne fa altri due, indicando in questi ultimi i mandanti dell’uccisione di Calabresi. Lui era solo l’assistente, l’autista dell’autore materiale del fatto. Ma andiamo, mio caro amico pentito, possibile che i carabinieri abbiano soltanto un disco e che a tutti coloro che accettano per quattro soldi di indossare la casacca dell’infame facciano recitare sempre la solita storia? Lo stesso per la ragazzina che nel processo di Roma contro gli anarchici (ancora in corso presso la Corte d’Assise), fra i continui “non ricordo”, ripete soltanto quello che ha imparato a memoria della relazione preparata dai carabinieri.
Ecco, c’è un fatto che i magistrati non sanno, che lo stesso pentito non sa, che nessuno sa, ed è il fatto che io so chi ha ucciso il commissario Luigi Calabresi, il 17 maggio 1972, sotto casa sua, in via Cherubini 6, a Milano, alle nove e un quarto del mattino. E questo taglia la testa al toro, definitivamente. Il faccione del pentito sta solo recitando un pessimo copione. Ma, non anticipiamo i tempi.
Ad aspettare il commissario in via Cherubini, c’era la vendetta. Un assoluto silenzio accolse il 20 dicembre del 1969 all’uscita dell’obitorio la salma di Pinelli. Erano le 15 e un quarto. Cominciava a piovere. Ci indirizzammo verso via Preneste. La moglie Licia aveva rilasciato un comunicato: “Desidero vivamente che i funerali di Pino Pinelli, pur aperti a tutti gli amici che vorranno prendervi parte, avvengano in forma dichiaratamente privata, senza la partecipazione di gruppi organizzati, di delegazioni o simboli”. Non so perché lei ebbe a fare questa dichiarazione, non certo per i motivi per cui da solo, nel mio cuore, anch’io ero arrivato alle stesse conclusioni: simboli, striscioni dei gruppi, forse le stesse bandiere al vento, sarebbero stati fuori posto. Una sola bandiera nera avrebbe dovuto essere presente, alla fine risultò che di bandiere ce n’erano più del necessario. Una corona di fiori portava una piccola scritta: “Gli anarchici tutti non ti dimenticheranno”.
Mi chiesi se non avremmo dimenticato Pinelli, oppure quello che gli era stato fatto. Il dubbio rimase fino al Cimitero Maggiore. Fossa 434, campo 76. Qui non ebbi più dubbi. E, insieme a me, i mille compagni presenti non ebbero più dubbi. Calabresi doveva essere ucciso. Addio Lugano bella. La vendetta è una questione di dignità. L’enormità del fatto non deve essere commisurata soltanto alla morte di Pinelli, e forse nemmeno alla stessa strage dei quindici morti e dei novanta feriti. Ciò costituirebbe una mera algebra giuridica, forse appena appena più corretta di quella che prevedono i codici. E, in questo senso, non mi interesserebbe. La vendetta è un eccesso, di per sé, non nell’attacco che realizza. Quindi, vedendo il rapporto nel senso contrario, l’uccisione di Calabresi, questa non è stata una vendetta commisurata, commisurata ai morti di Piazza Fontana o alla morte di Pinelli.
Anche vedendo le cose in questo modo si ricade nell’algebra giuridica di prima. La vendetta è quindi un eccesso. Non occhio per occhio, dente per dente, che di già nella formulazione biblica costituiva una razionalizzazione di precedenti comportamenti vendicativi imprevedibili, quindi un codice vero e proprio, mentre è parso ai più, erroneamente, una vendetta e basta. L’eccesso che si racchiude nella vendetta spazza il campo di qualsiasi rapporto di equivalenza, di qualsiasi commisurazione. Non è vendetta se non si trabocca nell’immane, nella cancellazione barbara del nemico, nella sua eliminazione o, almeno, in un arrecargli un danno di tale portata da rendergli impossibile l’oblio. Se la vendetta fosse commisurata, sarebbe il sistema sociale nel suo insieme ad impormela, ed eccomi quindi racchiuso in un codice, sia pure non scritto, ma sempre in un codice. L’ambiente mi obbligherebbe a vendicarmi, seguendo delle regole, in quanto in caso contrario sarei guardato male e male considerato se non mi vendicassi o se mi vendicassi in eccesso, dando origine a ripercussioni dannose per l’ambiente stesso.
Invece, se a sollecitarmi alla vendetta è la mia dignità offesa, è solo verso di essa che io sono responsabile, ed è con essa, quindi con la parte offesa di me stesso, con la mia coscienza, che devo fare i conti. E con me stesso non ci sono mezze misure, io costituisco con me stesso una totalità indissolubile, io sono il mondo, la totalità del mondo, e chi arreca offesa alla mia dignità cancella il mondo, mi distrugge come coscienza del mondo attraverso me stesso, e merita di essere tolto dal mondo. Certo, sono pochi a cogliere il senso profondo della propria dignità. È questo il mistero di certi comportamenti che ci sembrano inspiegabili. Nietzsche si sente offeso nella propria dignità di uomo di fronte allo spettacolo di un vetturino che frusta il proprio cavallo e non potendo resistere davanti al proprio mondo ucciso da quel bruto insensibile, decide di cancellarlo quel mondo, di cancellare il proprio mondo, di cancellarsi nella pazzia. Per lo stesso motivo, altri compagni, di fronte alla propria dignità offesa cancellano il mondo in altro modo, si cancellano nel suicidio. Questo modo di vedere la vita si sviluppa e finisce per diventare essenziale, man mano che ci si rende conto dell’assurdità delle regole formali che sanciscono la cosiddetta società, per non parlare delle leggi che fissano le condizioni di esistenza dello Stato. Leggi e comportamenti che a lungo andare appaiono non solo strumenti del nemico per asfissiare e rendere impossibile quel poco di libertà che anche in una società amministrata e controllata è possibile strappare, ma in se stessi, come vere storture, comportamenti aberranti anche quando appaiono intenzionati dalla migliore buona volontà. La critica della vita quotidiana produce una coscienza che nel tempo si fa sempre più acuta e sensibile, sempre più alacre nello scoprire ulteriori terreni di desolazione e di isolamento. Tutto intorno cadono così i luoghi comuni del possibilismo democratico, le illusioni della politica, le positività del movimento storico, le concessioni istituzionali, l’asetticità di certi riconoscimenti. Si fa terreno bruciato, ed allora occorre decidersi. Se la propria coscienza è capace di penetrare dentro la realtà, se scopre la trama che costituisce il tessuto dei rapporti sociali, quella trama fine e quasi impalpabile che spesso è coperta dai colori appetitosi dell’offerta con cui si veste la miseria del dominio, se arriva a fare chiara questa notte senza tempo, allora si sente offesa, profondamente offesa. È l’offesa dei millenni della schiavitù e dell’incarcerazione, dei millenni di sofferenze e genocidi, dei millenni di sottomissione a pochi gruppi dominatori. Nulla di quello che è stato il nostro passato merita di essere salvato, nulla mi è stato dato, e nulla sono riuscito a strappare al nemico, se non nell’ottica di una sua concorrenziale concessione diretta a farmi accedere al banchetto, sia pure per qualche briciola, per qualche riconoscimento di status del tutto marginale, per qualche striscia sul berretto, per qualche inchino da parte di imbecilli sornioni che si credono furbi.
E puoi anche riflettere per anni e anni su questi problemi, leggere e riflettere, fin quando ti senti stanco e triste, e non c’è nessuna pagina, nessuna parola, nessun gesto di uomo o di donna a te vicini che ti dica qualcosa di chiaro, definitivamente chiaro. Puoi remare nell’oscurità per anni, come i galeotti di un tempo, fino allo stremo, fino a quando cadi morto sul remo senza che gli altri se ne accorgano.
Invece, può accadere che un fatto ti illumini per un attimo il fondo della strada, che un fatto atroce ti faccia vedere in filigrana com’è veramente il nemico, di che pasta lo hanno messo al forno, da quale crogiolo infernale è uscita la sua anima. Se un tale avvenimento accade, se sei là anche tu, insieme a tanti altri come te, che sai che stanno vivendo la medesima esperienza traumatica, e li vedi, omoni grossi con le mani callose, ragazzini che cercano di darsi un atteggiamento, donne mature che corrono col pensiero agli anni della guerra, ai figli trucidati, fanciulle che vedono il loro amore, che avvertono come un segno di purezza del mondo, quasi sporcato da tanta protervia, e li vedi, tutti con le lacrime agli occhi, impotenti ma con i muscoli tesi, se un tale avvenimento accade con te dentro, non è più un qualsiasi accadimento, un fatto come gli altri (milioni di persone muoiono uccise barbaramente e vengono condotte al cimitero più o meno in fretta), ma quel fatto ha una carica diversa, porta con sé una tensione che non ti permette di avere tregua, ti svegli la notte sudato e, seduto sul letto, ti chiedi che stai facendo nel tuo letto, e se per caso non sei tu il morto che si gira nella tomba, mentre ad essere vivo, ben vivo, è proprio Pinelli, con la sua ingenua barba da operaio delle ferrovie. Mi rendo conto che tutto questo potrà sembrare un elenco di sensazioni avvertite da un cervello esaltato, da me che, lo devo confessare, quella sera al Cimitero Maggiore, fossa 434, campo 76, mi sono messo a piangere senza ritegno. E sia, mettiamola così, si tratta di ricordi che risentono dello stato emotivo del momento, e spesso questi stati emotivi esaltati, non potendosi esprimere sull’istante in qualche cosa di fattivo (prendere a pugni un poliziotto, ad esempio), si traducono in una frustrazione che fa scoppiare in lacrime.
E sia, sono d’accordo. Ma così ragionando si perde qualcosa d’importante, riducendo tutto ad una somma di singole persone che vivono singoli stati d’animo, si mette da parte la cosa essenziale, quella forza eccezionalmente importante che viene fuori da molte persone che avvertendo le medesime sensazioni emotive, sollecitate da sentimenti molto simili (nessuno identico, per carità, lo so bene), si sentono attratti uno con l’altro a costituire un insieme omogeneo che non ha bisogno di patti o contratti scritti o detti per costituirsi.
Improvvisamente, questa forza collettiva emerge ed è là, tangibile, posso toccarla, posso sentire la sua voce, posso lasciarmi prendere dalle sue suggestioni, indirizzare lo sguardo dove lei mi dice di guardare, vedere con i suoi occhi fatti di mille pupille quello che i miei poveri occhi miopi non vedono, ricordare ciò che la mia povera mente da sola non può ricordare. Improvvisamente, come dalla testa di Zeus, di tutto punto armata, esce l’idea di giustizia. Ma è una ben strana idea, perché non si appoggia a nessun patto, a nessun ordinamento preferenziale. Non è un’idea che vuole rimettere le cose al loro posto, scambiare il cadavere di Pinelli con quello di Calabresi, non sono prodotti fungibili. Non è un’idea che vuole garantire all’azione rivoluzionaria, genericamente considerata, una legittimità di continuazione: che fiducia possono avere gli sfruttati in rivoluzionari che senza reagire si fanno gettare dalla finestra come una scatola di roba vecchia. No, nemmeno questo. Non è un’idea che vuole essere conosciuta, fatta propria dalla gente, tanto è vero che non ci saranno rivendicazioni o chiacchiere politiche da parte di organizzazioni specifiche di nessun genere, e dire che in quel torno di tempo strutture nascenti ce n’erano diverse. Non è un’idea che si alza più alta delle altre per richiamare all’ordine turbato dal comportamento fuori delle regole, dai misfatti compiuti da un certo commissario Calabresi, dopo tutto non è certo normale che un fermato in questura, durante un interrogatorio, venga buttato fuori dalla finestra.
Se questo mondo si basa sulla giustizia commisurata, sui calcoli numerici di un dare e un avere, di un punire per il torto fatto e di fare un torto per la pena subita, si tratta di un mondo che non ha niente a che fare con quell’idea di giustizia venuta fuori collettivamente in quel momento, quella sera, nel Cimitero Maggiore di Milano. Ecco quindi che quella sera, senza che nessuno lo volesse o lo sapesse, è venuta fuori un’idea di giustizia che prima non c’era, un’idea che travalica e rende risibile il singolo desiderio, la singola fantasia di sparare in bocca al buon commissario Calabresi, desiderio e fantasia coltivati senz’altro dalla quasi totalità dei presenti, ma come tutti i desideri e tutte le fantasie, poco dopo, col ritorno alla vita quotidiana, svaniti nel nulla.
Invece quest’idea di giustizia (che si potrebbe definire “proletaria” se, come giustamente è stato fatto notare, su questo termine non fosse piovuta la polvere dei millenni a renderlo inutilizzabile), che non sapendo come chiamare continueremo a chiamare così, semplicemente, giustizia, quest’idea di giustizia ha continuato il suo cammino in tutti noi, ci ha mantenuti tutti insieme uniti, compagni che non mi sono mai stati vicini, che erano presenti quella sera lì, che poi ho rivisto poche volte altrove, in tutt’altre faccende affaccendati, loro ed io, compagni per i quali, diciamolo chiaramente, nutro pochissima stima, se non proprio avversione e disprezzo, ebbene per il semplice fatto che anche loro fossero lì quella sera, tutte le volte che la voce lontana ma vivissima della giustizia mi chiama, mettendomi in subbuglio il cuore, anche quei compagni torno a sentirli vicini.
Ecco perché io so chi ha ucciso il commissario Luigi Calabresi, il 17 maggio 1972, sotto casa sua, in via Cherubini 6, a Milano, alle nove e un quarto del mattino. Quei mille, e più, compagni presenti alla fossa 434, campo 76, del Cimitero Maggiore di Milano, abbiamo tutti premuto il grilletto. Nessun perdono. Nessuna pietà.
Addio Lugano bella.
Catania, 12 luglio 1998
Link Download
Note dell’Archivio
-Prima edizione: Catania, Dicembre 1998
-Seconda edizione: Catania, Febbraio 1999
-Terza edizione: Trieste, Aprile 2007